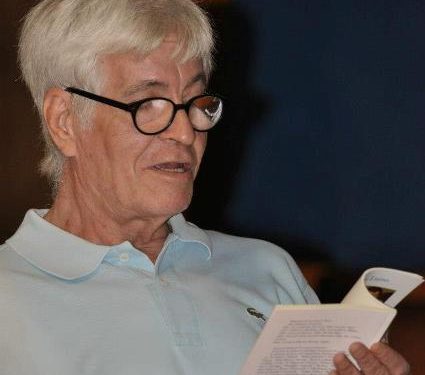“È un’amaca questa mia ora strana
sospesa fra due alberi di carta
uno che mi sostiene il cuore in croce
e l’altro il mio cervello sempre in forse”
Caro Mimì, ricordi?
Lo facevamo per celia.
Appena ti scorgevo, specie
se eri in compagnia d’altri incliti rappresentanti della cultura bitontina, mi
genuflettevo dinanzi alla tua sublime altezza e tu mi porgevi con regale
distacco il dorso della mano, affinché io la sfiorassi con le mie labbra
deferenti nello sgomento generale.
Era il tuo (nostro)
caustico sberleffo al conformismo altisonante della intellighentia cittadina.
Ti sentivi, in quella, come
il tuo amato Ferlinghetti che sognava di tangere i glutei ad una statua
classicheggiante.
Eri fatto così.
Credo che tu non abbia mai
indossato una maschera che fosse una, in tutta la tua vita.
Manco per un secondo.
Era già questo un modo per
dire che ti faceva ribrezzo l’ipocrisia.
Eri, infatti, la stecca
impavida nel coro che sbalordiva.
La nota stonata che non
poteva piacere ai potenti.
Il saggio che passava per
matto solo perché diceva la verità.
Vergavi i tuoi pensieri
prima su L’Obiettivo e poi su Primo piano dell’amico Mimmo, sempre “contro corrente”.
E non facevi mai
prigionieri.
I tuoi articoli erano
tempeste d’estate che spazzavano via tutto quello che ti sembrava immorale e iniquo.
Alto quanto una pertica,
neve impigliata nei capelli, occhiali grandi che non nascondevano lo sguardo,
anzi.
Sembravi un marinaio, che
aveva un grumo di nostalgia appeso sul cuore, come di chi aveva attraversato il
mare misterioso della vita e adesso cercava il ricordo di sé stesso nella
solitudine dell’anima.
Con ironia tranchant.
Incredibile quella volta
che il preside Pastoressa buonanima ti fece i complimenti per una tua dotta
citazione, chiamando in causa addirittura Kant, e tu ribattesti acuminato: “Era Leibniz, professore, non Kant”.
Un anno fa, ricordi, nel
chiaroscuro del Torrione angoino, insieme al tuo affezionato allievo Alessandro e al federiciano Ciccio, parlammo di Monna Poesia e tu
incantasti tutti con la tua teoria del “forse”.
Avverbio che non sarà mai
verbo eppure in grado di cambiare le sorti di una frase e spedirla diritto nel
limbo dell’inquietudine.
Era lo specchio dell’incerta
nostra esistenza.
La prima tua silloge di
liriche è del 1986, “La condizione del cuore”, l’ultima del 2008, “Il nuovo
seme del canto”, nei ventidue anni intercorsi hai firmato pure “Il discorso del
fiume”, “Concerto barocco”, “Vento di cicale” e “L’arsura delle ali”.
Versi autentici e immaginifici.
Mondi frastagliati e dolenti.
Sentieri fascinosi e atroci.
Avevano la crudele musicalità dei giorni, ora soave, ora ruvida.
Tutto questo era la tua
poesia, che ti aveva meritato cinquanta e passa riconoscimenti su e giù per lo
Stivale.
Ieri sera, come fosse un
pellegrinaggio, son venuto a trovarti.
Il cielo aveva un dolce
chiarore lontano e sembrava tremare d’emozione.
Ho abbracciato, nella sera che piano scendeva fra gli ulivi muti, tuo figlioPaolo ed il suo sorriso ferito.
Nella camera ardente, la
tua consorte era perdutamente abbandonata alla parete e stringeva mani con
silenzioso dolore.
Per un attimo, ho pensato.
Mimì, ora, scosterà la
trina leggera che lo ricopre, con un ghigno prendingiro si leverà e salutandomi:
“U strunz, no viin dou”.
Mi allungherà il dorso
della mano con sovrana eleganza ed io m’inginocchierò e capirò che è tutto uno
scherzo.
E invece niente.
Sei rimasto
disteso lì dentro, immobile, assottigliato dalla sofferenza.
Sono andato via, con passo
pensoso.
“Si spezza la luce della carne/e si sotterra il vento delle porte”,
scrivevi.
Ecco, dovevo alzare gli
occhi, perché non si trattava più di terrena vicenda.
L’ho fatto.
E giuro d’aver visto una
piccola nuvola con due occhi di stelle leggere una poesia che iniziava così: “Scompagina il mio canto, Dio…”.
Ciao Mimì, già ci manchi…