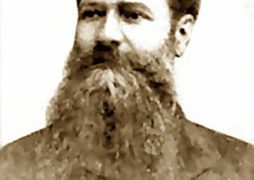Tutti si ricorderanno di Heinrich Schliemann , lo scopritore di Troia e Micene e di Arthur Evans, che rivelò al mondo nientemeno che il favoloso Palazzo di Minosse, ma cosa hanno in comune questi due eminenti archeologi, il fatto che il mondo o meglio quello accademico non li reputasse tali, ma quasi colpevoli per i risultati sorprendenti che avevano prodotto, senza la preparazione o le conoscenze scientifiche adeguate, che li inserisse in quei circoli elitari, che potessero consacrare le loro scoperte.
Oggi però parliamo di un altro pioniere dell’archeologia, che per mancanza di “titoli”, fu accusato dai suoi colleghi di “dilettantismo” dettato da un’”insufficienza di metodo scientifico” adottato nelle sue ricerche, parliamo di Isidoro Falchi, lo scopritore dell’Etruria.
Isidoro Falchi era un medico nato a Montopoli Val d’Arno, in provincia di Pisa, il 26 Aprile del 1838. Anche se in ristrettezze economiche, dotato di spiccata intelligenza, consegue la laurea in Medicina all’Università di Pisa. In seguito matura una passione per la Storia antica a l’Archeologia e inizia a compiere indagini private che lo portano a pubblicare l’opera: “Trattamenti popolari sulla storia della Maremma e specialmente di Campiglia Marittima.” In questo libro Falchi per la prima volta si sbilancia nell’ipotizzare una possibile ubicazione delle due città etrusche di Populonia e Vetulonia, che erano sconosciute da secoli e altri prima di lui avevano cercato invano di individuarle.
Grazie ad una intensa ricerca d’archivio e al ritrovamento di tre monete dove compariva la dicitura “VATL”, l’antica denominazione etrusca di Vetulonia, provenienti dalla località nota come Colonna di Buriano, inizia nel suddetto sito gli scavi e nel 1880 riporta alla luce i resti e le vestigia dell’antica città di Vetulonia. La notizia ebbe un impressionante risonanza in tutto il mondo accademico, con i suoi cattedratici, che imbarazzati per essere stati scavalcati da un archeologo dilettante, inaugurarono una campagna di diffamazione, puntando maggiormente a screditarlo agli occhi del pubblico per la sua assenza di “qualifiche”. Ciò nonostante nel 1888 gli fu comunque riconosciuta la paternità della scoperta, alla quale ne seguirono altre, portando alla luce, questa volta nel sito di Populonia, sepolture e strutture funerarie etrusche, corredi sacri e due elaborati vasi d’oro.
Lo ricordiamo con le parole di Luigi Pernier, il primo direttore della scuola Archeologica Italiana di Atene, che paragonandolo a Schliemann scrisse queste testuali parole: “In entrambi l’ideale fuori dalla cerchia professionale, in entrambi il successo della scoperta pari all’ardore e alla tenacia delle ricerche.”