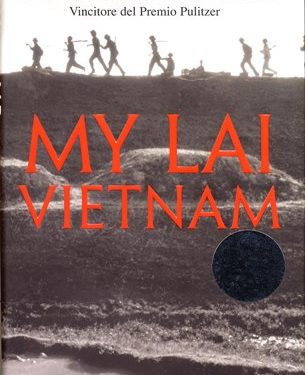Il racconto
della verità è, o meglio, dovrebbe essere la stella polare di ogni giornalista
desideroso di vivere la sua professione come un servizio al genere umano.
Grazie al contributo di grandi colleghi siamo talvolta venuti a conoscenza di aspetti della realtà, avvenimenti storici che,
per interessi più o meno occulti, qualcuno avrebbe preferito che fossero passati
sotto silenzio.
E’ il caso di “My Lai Vietnam”, un’inchiesta realizzata dal giornalista
statunitense Seymour Hersch, per la quale ricevette, nel 1970, il Premio
Pulitzer, la più prestigiosa onorificenza nel giornalismo americano.
L’opera, edita nel 2005 dalla casa editrice Piemme, racconta da vari punti di
vista quel che avvenne in un villaggio sudvietnamita il 16 marzo del 1968,
quando i soldati statunitensi della Compagnia Charlie, della 11a Brigata di
Fanteria Leggera, agli ordini del tenente William Calley, irruppero in un
piccolo villaggio del paese asiatico, ritenendolo covo di guerriglieri, e
massacrarono gli inermi abitanti, principalmente anziani, donne, bambini e
persino neonati. Il tutto per vendicare la morte di alcuni commilitoni uccisi dalle
trappole dei vietcong.
La strage costò la vita a 347 persone, quasi tutte
disarmate, considerando che le armi rinvenute furono solo 128. La mattanza fu
fermata solo dall’arrivo di un elicottero di ricognizione dell’esercito
americano, i cui occupanti, guidati dal pilota Hugh Thompson, dopo aver visto
con i propri occhi quell’assurda follia, non esitarono a puntare le armi contro
i loro stessi commilitoni, minacciando di aprire il fuoco. Fu così possibile
evacuare il villaggio e salvare i pochi ancora in vita. L’episodio passò alla
storia come massacro di My Lai e fu uno degli episodi più cruenti della guerra in
Vietnam.
Nessuna di quelle morti ha mai avuto giustizia. Soldati e ufficiali furono
risparmiati dalla legge e, mentre i superiori non furono considerati colpevoli
e furono assolti. Solo il tenente Calley fu condannato all’ergastolo, salvo poi
essere graziato dal presidente Nixon.
Seymour Hersch, nell’opera, ricostruisce la cronaca di quel giorno attraverso
diversi strumenti. Prima di tutto i rapporti dell’esercito, che tentò di
sminuire la portata della tragedia, e le testimonianze dei soldati coinvolti,
carnefici e salvatori. Furono, infatti, gli stessi carnefici che, in preda ai
sensi di colpa o nel tentativo di scaricare le colpe sui superiori,
raccontarono raccapriccianti dettagli sull’accaduto. “Meritiamo la galera per
quel che abbiamo fatto” è l’amara riflessione di uno dei militari, riportata in
un’intervista presente nell’opera.
Altro strumento utilizzato dall’autore è l’analisi dell’opinione pubblica negli
Usa, nel Vietnam del Nord e nel Vietnam del Sud, attraverso lo studio delle
varie versioni del massacro date dalla stampa nei tre paesi.
Un’analisi da cui
emerge un’opinione pubblica statunitense che, complice l’iniziale scarsa
informazione, si rivela dalla parte dei soldati. L’episodio scosse fortemente
la popolazione nordvietnamita e, complice la stampa che ingigantì l’entità
della catastrofe, contribuì, forse, a rendere più agguerrita la resistenza
contro l’invasore americano. Nel Vietnam meridionale, invece, nonostante
l’ondata di indignazione fosse alta, governo e vertici militari furono più
interessati a limitare la diffusione delle notizie per salvaguardare l’alleanza
con gli Stati Uniti.
Una lettura niente affatto pesante che fa riflettere di come la guerra possa
trasformare in spietati assassini ragazzi normali, “figli di una nazione democratica e civile come gli Stati Uniti” che,
per giustificarsi, affermarono: “Ho solo eseguito gli ordini”.
Una frase
che più volte abbiamo sentito pronunciare, nelle aule dei tribunali chiamati a
giudicare i crimini di guerra, da parte di crudeli ufficiali nazisti, dagli spietati
Khmer Rossi cambogiani o dei responsabili dei massacri nell’ex Jugoslavia.
Ma la cosa ancor più triste è che, nel frattempo, da quel maledetto giorno di
marzo del ’68, più volte la storia si è ripetuta.