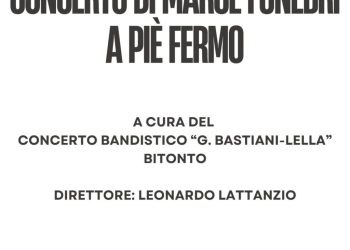Uno si chiama Giuseppe Scibilia, 47 anni, e l’altro Angelo Sigona, che di primavere ne aveva 25.
Molto probabilmente alle giovani generazioni questi due nomi non vorranno dire alcunché, ma non è una loro colpa.
Quei due uomini (o meglio, anche quei due uomini) sono, invece, il simbolo di tante cose. Del Belpaese del 1968, che stava cambiando e voleva cambiare. E, quasi, si sentiva in dovere di cambiare dopo gli anni d’oro del Centrismo e degli anni ’50, che però non sono stati così per tutti.
Di troppe classi sociali che chiedono risposte alle loro domande, per troppi anni inevase. Donne. Studenti. Metalmeccanici. Lavoratori. Sindacati.
Di uno Stivale, quello italico, che stava per imparare a conoscere gli attentati terrostici, destra e sinistra, che colpiranno ovunque. Banche, piazze, comizi, treni, giornalisti, politici, imprenditori, forze dell’ordine. Tutto ciò che era simbolo del nemico da abbattere: la borghesia e la società borghese.
Di una Italia diversa, in cui la tensione, quella per i diritti sociali, si tagliava a fette.
Lavoratori, allora. Sindacati, dunque. Non a caso, perché in quegli anni si lottava, si scioperava, nelle grandi fabbriche e per strada, per il rinnovo dei contratti e per la messa nera su bianco dello Statuto dei lavoratori, arrivata nel 1970. Ma che, due anni prima, sembrava una chimera.
E quando si pensa a quella conquista, ci si deve ricordare anche di loro: Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona. Appunto.
Il calendario dice 2 dicembre 1968. Mezzo secolo esatto fa. Anche se, in realtà, questa è una strage che ha il principio dieci giorni prima, il 25 novembre.
Tutto ha inizio quando i braccianti agricoli aderenti alle tre maggiori organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) decidono di intraprendere una grande azione unitaria. Si trattava di ottenere un aumento del 10 per cento (sì, esattamente il 10 per cento, che significa 300 lire) sulle paghe, ma soprattutto il riconoscimento di un elementare diritto fino ad allora negato: la parità di trattamento salariale tra addetti a uno stesso lavoro in due zone diverse di una stessa provincia. L’Italia di 50 anni fa, infatti, era un Paese in cui si poteva ancora morire battendosi non per equiparare i salari di Avola a quelli di Milano, ma per ottenere che il bracciante di Avola abbia un salario non inferiore a quello del bracciante di Lentini. Avola e Lentini, entrambe in provincia di Siracusa. Ma non uguali tra loro, perché quella provincia era divisa in due zone agricole: la prima, denominata A, comprendeva i Comuni della zona nord, quelli più ricchi; la seconda, B, comprendeva quelli dell’area meridionale della provincia, ipiù poveri.
Nelle due zone erano applicati differenti orari di lavoro (7 ore e 30 contro 8 ore) e differenti salari (3.480 lire al giorno contro 3.110). La lotta dei braccianti poneva, quindi, una elementare rivendicazione egualitaria.
Le richieste, in questa zona della Sicilia, non sono affatto nuove, perché già due anni prima c’erano stati violenti scontri con le forze dell’ordine.
Ebbene, di fronte al rifiuto degli agrari di prendere contatto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, un numero impressionante di lavoratori agricoli, ben 32mila, incrociano le braccia abbandonando i “giardini” dove in quei giorni stavano maturando gli aranci. Ma ben presto, dalle piazze dei paesi, i braccianti in sciopero dilagano lungo le strade provinciali, innalzando blocchi di pietre nella speranza che le interruzioni del traffico attirino l’attenzione del governo.
E questo avviene in effetti. Ma la risposta non è quella che quell’esercito di disperati si aspettava. Lo Stato decide di intervenire usando il pugno duro, durissimo.
E così, mentre un centinaio di braccianti agricoli sono intorno a uno sbarramento di pietre eretto al 20° chilometro della statale 115, poco prima del bivio per il Lido di Avola, nove camionette cariche di agenti, per complessivi novanta uomini, tutti muniti di mitra, bombe lacrimogene, elmetto d’acciaio, arrivano da Siracusa e si arrestano di fronte al blocco intimandone lo smantellamento immediato.
Ed è da questo momento in poi che inizia il dramma di una comunità. La cosiddetta strage di Evola. Da un lato ci sono i braccianti che iniziano a lanciare le pietre. Dall’altro i poliziotti che rispondono scaricando le bombe, ma il gas, invece di intossicare gli operai, investe, trasportato dal vento, gli stessi poliziotti i quali vengono contemporaneamente respinti da una seconda bordata di pietre, anche perché nel frattempo accorrono contadini di altri Comuni vicini.
Loro, gli uomini in divisa, perdono la testa e iniziano a sparare all’impazzata. Tanto, tantissimo. Un inferno di fuoco che durerà circa mezz’ora, tanto da raccogliere da terra più di 2kg di bossoli.
Il problema è che al suolo ci sono anche 48 feriti, alcuni gravi, e un cadavere, quello di Angelo Sigona. Giuseppe Scibilia, invece, muore in ospedale.
Per la prima volta, dopo l’avvio della stagione dei governi di centrosinistra, la polizia uccide dei lavoratori durante uno sciopero.
Il 1968, anno della contestazione e della presa di parola, termina nel sangue.