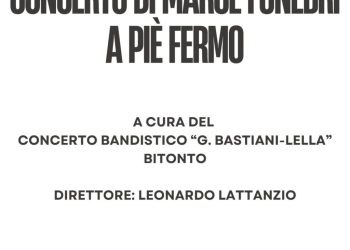«Ci siamo allenate tutto il pomeriggio, perché in quel fine settimana ci sarebbe stata la partita e volevo fare bella figura. Avevo una tuta blu e stavo rientrando a casa. Erano le sette di sera, mi hanno caricato su un furgone, volevo essere gentile e dar loro indicazioni stradali. Mi hanno violentata e picchiata, poi buttata su un prato come si fa con un sacco di foglie. In ospedale, con prognosi di 15 giorni, un giornalista mi ha chiesto com’ero vestita e mio padre l’ha preso per un braccio e l’ha buttato fuori dalla stanza».
È una delle storie che sono state raccontate dalla mostra che si intitola, appunto, “Come eri vestita? – What were you wearing?”, iniziativa itinerante contro gli stereotipi che colpevolizzano le donne vittime di violenza sessuale e il loro modo di vestire, al posto di condannare a prescindere la violenza. L’obiettivo è sancire quel che dovrebbe essere palese: il modo di vestire non è una attenuante della violenza e non è una scusa, ma l’unico colpevole dell’aggressione è chi la compie.
Una mostra a cura del Centro antiviolenza comunale “Io sono Mia”, organizzata nell’ambito delle attività previste dal Programma Antiviolenza Ex-Change finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato dall’ambito territoriale di Bitonto – Palo del Colle. Il progetto è nato e promosso per volontà dell’Università dell’Arkansas e la prima mostra è stata allestita per la prima volta negli Stati Uniti nella primavera del 2013.
L’Associazione Libere Sinergie ha voluto, dunque, replicare l’evento, contestualizzandolo nell’ambiente socio-culturale italiano, per sensibilizzare la gente sul tema della violenza sulle donne, a partire dalla domanda ricorrente posta a chi ha subito molestie o violenza sessuale, che è, appunto, “Come eri vestita?”.
Diciassette sono state le storie raccontate dalla mostra. Storie di donne comuni. Per ogni storia un abito. Quello indossato nel momento in cui la proprietaria ha subito violenza. Storie diverse e abiti diversi. C’è la divisa da lavoro, il tailleur, la tuta, il camice da medico, il vestito della sposa bambina, un normale abito da sera, un innocentissimo maglione di lana con pantalone annesso. Tutti abiti non particolarmente succinti, atti a sottolineare come il vestiario della vittima non abbia alcuna attinenza con la volontà dell’aggressore di perpetrare la sua violenza.
Ad essere raccontate, storie di ragazze violentate da amici o addirittura da parenti, aggressioni perpetrate da sconosciuti per strada, violenze messe in atto da datori di lavoro e tante altre. C’è anche la storia di Paola Labriola, la psichiatra uccisa nel 2013 da un suo paziente. Il suo camice è esposto come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne anche nei luoghi di lavoro, con uno sguardo particolare alle operatrici sanitarie, spesso vittime di molestie e aggressioni.
Dopo aver viaggiato per tutta l’Italia, l’iniziativa è quindi arrivata prima in Puglia grazie al contributo di Sud Est Donne, associazione da anni impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. E, poi, a Bitonto. È stata inaugurata il 28 febbraio e si è chiusa ieri. Diverse sono le scolaresche che hanno avuto modo di assistere, grazie alle scuole che hanno aderito all’invito degli organizzatori, per fare in modo che i ragazzi possano riflettere su un tema delicato come la violenza di genere.
«La violenza è trasversale. Abbiamo voluto aggiungere ai 17 abiti la nostra maglia della speranza che è dedicata a tutte le donne coraggiose che hanno trovato il coraggio di denunciare e che recita “Hanno provato a seppellirci, non sapevano che eravamo semi”» spiega Ivana Stellacci del Centro Antiviolenza “Io sono mia” che, nel 2022, ha seguito ben 63 casi di violenza e, dall’inizio dell’anno, già 14 donne ha bussato alle porte del Cav.