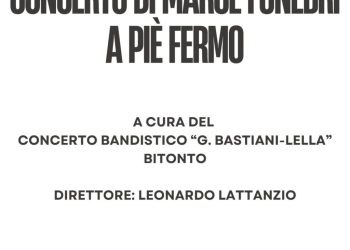Tutto inizia alle 7.15 del 1° dicembre 1923.
Ben prima del Vajont e del disastro – di cui parleremo nelle prossime settimane – del Molare.
Il guardiano della diga del Gleno, in provincia di Bergamo, esce dalla sua baracca di legno per il solito giro di controllo. Sulle Alpi bergamasche piove ininterrottamente da due mesi e da qualche ora ha anche iniziato a nevicare. La diga è nuova di zecca, anche perché i lavori erano finiti solo tre mesi prima, e la sua costruzione rientra in un Piano strategico varato dal Governo anni prima per venire incontro alla crescente domanda interna di energia elettrica. Fondamentale in un Paese come l’Italia dove mancano i combustibili fossili.
L’opera era un portento, per l’epoca. Duecentosessanta metri di lunghezza, quasi 100 di altezza, un vero e proprio gigante pensato per imbrigliare i torrenti Povo e Nembo e creare così un bacino da sei milioni di metri cubi d’acqua. Tuttavia, nonostante i lavori di realizzazione fossero finiti solo da tre mesi, la diga aveva già qualche problema e, quel giorno, a causa della pioggia incessante, era al massimo della capienza.
E non solo, perché in tanti sanno nei villaggi circostanti che sono stati utilizzati materiali sbagliati, che per risparmiare è stata usate calce al posto del cemento e pure che il progetto è stato cambiato senza autorizzazione durante i lavori.
Qualcuno, quindi, ha più di una preoccupazione ma non può immaginare che quella mattina sarebbe accaduta una catastrofe di proporzioni gigantesche.
Ripartiamo dalle 7.15 del 1° dicembre 1923, allora. Arrivato a metà del suo giro di controllo, il guardiano si ferma di colpo, guarda in alto e vede un grosso macigno staccarsi della sommità e precipitare nel buio sottostante. Nota una grossa riga nera che taglia in due la parete della diga. Ha già capito di cosa si tratta, ma vuole essere sicuro. Così accende un cerino per vedere meglio e sì, si tratta proprio di una grossa crepa. La diga sta collassando.
È una questione di istanti.
Fa appena in tempo a mettersi in salvo su di un macigno che tutto il fianco sinistro della diga crolla su se stesso liberando sei milioni di metri cubi d’acqua. Ovviamente infermabili. Uno tsunami a 1.500 metri d’altezza che spazza via tutto quello che trova sul suo cammino. Case, cascine, stalle, chiese, ponti, persone e animali. L’onda travolge anche le centrali elettriche. Scoppiano incendi. Il tutto dura 45 minuti e alla fine verranno recuperati 356 cadaveri, ma i morti sono di più. Molti più. Circa 500.
Immediatamente – e qui per fortuna siamo maestri – scatta la gara di solidarietà. Da tutta Italia arrivarono aiuti e soccorsi.
Il giorno dopo giunge sul posto persino re Vittorio Emanuele III, seguito a distanza di poche ore dal procuratore della corona e Gabriele D’Annunzio.
Le indagini sull’accaduto, però, non sono per nulla diverse da quelle che siamo abituati a sentire. Le vicende giudiziarie, infatti, sono scandite da una lunghissima sequenza di rinvii, rimpalli di responsabilità, sfilate di docenti universitari e periti, e si sono concluse con condanne miti al titolare della ditta che aveva ottenuto la concessione e l’ingegnere autore del progetto.
Poi il silenzio, pure “comprensibile” se ci pensiamo un attimo. Il Fascismo, appena arrivato, non poteva permettersi figuracce e insabbiare era la cosa da fare. La sola.
Solo gli abitanti della valle, anno dopo anno, hanno ricordato i loro morti e recentemente la storia di questa tragedia ha conquistato spazio sui giornali, ispirando libri, uno spettacolo teatrale, una canzone composta da un cantautore del luogo e una puntata di “Voyager”.